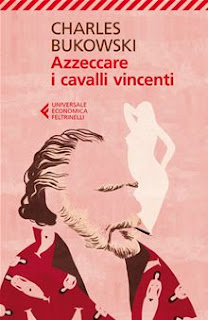sabato 28 settembre 2013
Strindberg è stato indubbiamente
un grande artista ma nel privato doveva essere un uomo pressoché insopportabile
o quanto meno difficile da trattare. Tale è l’impressione che emerge dopo la
lettura di questo romanzo autobiografico, Autodifesa
di un folle, scritto tra il settembre del 1887 e il marzo del 1888, che, se
è ricco della verve creativa dello
scrittore e drammaturgo svedese, al tempo stesso denuncia la sua irritabilità, la
sua instabilità, le sue manie, la sua
gelosia patologica. Perché sebbene questo scritto nasca per denunciare la
depravazione della moglie Siri von Essen, descritta nel personaggio di Maria,
in realtà si rivela un boomerang e un’arma
a doppio taglio.
A uscire da quest’autodifesa malconcio e
ferito è Strindberg stesso, di cui emergono la monomania, la misoginia, la
teatrale ed enfatica disperazione, i
tratti, insomma, di un’alienazione mentale di cui egli incolpa in qualche
occasione la moglie. Ella era una civetta, una donna viziata, una madre a volte
disattenta, indubbiamente, che riservava
i pezzi migliori di carne per il suo cagnolino dando gli scarti al marito, la mente alterata dello scrittore svedese ne
fa un mostro, però, ben aldilà delle sue
reali mancanze, tutto sommato minime.
Strindberg non era il libero pensatore che impersonava nei suoi scritti, era un
maschilista della peggior specie, un misogino inferocito, con, malcelati, i tratti di un patriarca borghese con idee
vetuste.
Queste si trasmettono al romanzo
che, se pieno di vita e di rabbiosa e furente vitalità, è però attraversato da
una misoginia che pare davvero patologica, da una paranoia strisciante, a
tratti anche da una rabbia insensata. E’ la deriva di un romanticismo ormai
datato, che leggiamo in queste pagine, dove l’idealizzazione della donna, elevata
a Madonna, è solo il preludio della sua sconsacrazione, del suo decadere a
donnaccia. E’ un procedimento ben noto alla psicanalisi che trova in queste
pagine terreno fertile, il terreno in cui è nata.
Intendiamoci, Strindberg è uno scrittore abile, dotato di un pensiero sufficientemente lucido e insieme sufficientemente schizoide per creare un’opera d’arte riuscita, ma se il suo intento era difendersi dalle accuse della stampa del tempo, fallisce clamorosamente. Più che un’autodifesa il romanzo risulta così un’autodenuncia involontaria.
Come non parteggiare per la
moglie - che pure ha i suoi limiti - osservando
il delirante vittimismo di Strindberg, che incarna con violenza idee arretrate
sulla condizione femminile, che se non era quella della schiava, come voleva il
nascente femminismo di allora, era, però, indubbiamente, fonte d’isteria e
alienazione? Perché tutto si svolge all’interno dell’ambiente aristocratico e
borghese, la moglie di Strindberg, con sciocche velleità da attrice, non è
certo un personaggio dalla moralità impeccabile, ma farne un mostro, come
vorrebbe lo scrittore svedese è davvero
eccessivo. Così da questo romanzo esce uno Strindberg patetico, ridondante,
delirante, che scioglie le sue ragioni nell’acido dei suoi stessi eccessi di
paranoia, anche se è capace in fin dei conti di denunciare gli orrori del
matrimonio borghese, da un lato solo, però,
quello maschile, con poca o nessuna
comprensione verso i soprusi che la donna è costretta a subire.
Autodifesa
di un folle è dunque un romanzo stilisticamente avvincente in cui, però,
vengono diffuse idee datate legate a una misoginia che ha fatto,
fortunatamente, il suo tempo, almeno a livello di superficie culturale, perché
se scaviamo in profondità probabilmente le idee di Strindberg riscuotono ancora
credito. La colpa principale della moglie è quella di non corrispondere all’immagine
idealizzata che lo scrittore aveva creato nella sua mente. Colpa che non poteva
essere perdonata, pena la perdita d’identità per lo scrittore svedese.
E’ questo un romanzo in cui il delirio, però, assurge
all’arte, Strindberg ci fornisce un ritratto di se stesso ambiguo: se da un
lato egli è da ammirare per le capacità artistiche, per la moralità e la rettitudine, dall’altro la
sua delirante gelosia, la sua misoginia miserabile, il suo patriarcale dispotismo, venato di idee
paranoiche, sono da biasimare. La bellezza nel romanzo è nella sua,
probabilmente involontaria, sincerità; nel tentativo di accusare la moglie
Strindberg scivola sulla buccia di banana di un patetismo d’altri tempi,
regalandoci più che il ritratto della depravazione muliebre, come avrebbe
voluto, una propria caricatura, un autoritratto impietoso, uno schizzo della
propria follia e insieme della follia di un’intera epoca che diede a Sigmund
Freud materia per i suoi studi sulla nevrosi e sull’isteria. Epoca in cui
sostanzialmente sia gli uomini che le donne, in modo diverso, sembrano vittime
di un’identica alienazione, ancora più insidiosa perché non riconosciuta
culturalmente e soffocata sotto strati di ipocrisia.